EVOLA E LE ROVINE ELETTRONICHE DEGLI ANNI NOVANTA
1. Millenovecentonovantanove
Nel 1989 gli scenari nazionalisti e internazionali sono ancora una volta cambiati, e di molto. La salita al potere di Gorbaciov in Unione Sovietica ha causato una serie di colpi e contraccolpi, che alla resa dei conti, sta provocando, almeno in apparenza, una non certo prevista messa in discussione della spartizione di Yalta: perestrojka e glasmost, con il conseguente abbandono della “dottrina Breznev” sulla sovranità nazionale limitata, hanno prodotto in cinque anni una situazione ancora in movimento e che ha visto il 1989 come l’anno in cui, a mezzo secolo dallo scoppio della seconda guerra mondiale, due paesi dell’Est europeo, Polonia e Ungheria, tramite percorsi diversi, dal basso il primo, dall’alto il secondo, sono riusciti a staccarsi dalle concezioni marxiste originarie della vecchia classe dirigente ed a seguire le indicazioni di rinnovamento date dalla casa-madre di Mosca, a modificare gli assetti interni, a porre in minoranza o a far cambiare direzione ai partiti comunisti nazionali, seguiti su questa via impetuosamente dalla Germania dell’Est e dalla Cecoslovacchia, più cautamente dalla Bulgaria.
Ma non solo questo: di destinare risorse al miglioramento del livello di vita, distogliendole dal potenziamento continuo dell’apparato militare, dalla cosiddetta “corsa agli armamenti” iniziata negli Anni Cinquanta, ha indotto Gorbaciov a sganciarsi dall’Afghanistan, a tagliare i fondi destinati a paesi “fratelli” come Nicaragua, Cuba e Vietnam, ad aprire negoziati con il Giappone per formare un trattato di pace che Tokyo si è sempre rifiutato di siglare a causa dell’occupazione sovietica delle Isole Kurili nell’ultima settimana di guerra. Quest’ultimo punto, che sembra minore, ha un’importanza forse decisiva: se Mosca restituisse quei territori al Giappone sarebbe un primo cedimento sulla questione dei confini usciti dallo sconvolgimento dell’ultimo conflitto e non potrebbe non avere ripercussioni sulle tensioni nazionalistiche che agitano i confini dell’impero sovietico: le repubbliche baltiche e quelle caucasiche sono sempre più in fermento. Addirittura, venuti ufficialmente alla luce gli accordi segreti del patto Ribbentrop-Molotov del 1939, Lettonia, Estonia e Lituania reclamano una vera e propria indipendenza.
Inoltre, dopo il crollo reale e simbolico del “muro di Berlino” si è persino riaperta una “questione tedesca” considerata morta e sepolta da tempo: non solo il problema della riunificazione delle due Germanie, ma addirittura quello dei territori del Terzo Reich inglobati dalla Polonia dopo il 1945 (il confine Oder-Neisse), nonostante l’assicurazione ufficiale di Bonn di non avere più pretese su quelle regioni a tutti gli effetti tedesche come la Prussia orientale. In altri termini, dopo quasi mezzo secolo di forsennato internazionalismo stanno riemergendo, sono riemersi, diffusi fermenti nazionalisti, basati sulla comunanza di territorio, di lingua, di religione, di cultura. Rivendicazioni che sono alla base proprio delle insistenti richieste ufficiali dei popoli forzatamente annessi dal 1918 in poi nell’Unione Sovietica. Rotto un argine, sembra che l’inondazione di rivendicazioni non possa più fermarsi: nonostante gli alti ed i bassi, il fuoco cova sotto la cenere e la conclusione potrebbe essere duplice, anche se può apparire fantapolitica: o una caduta di Gorbaciov ad opera di coloro i quali temono una disgregazione dell’impero sovietico; o, entro il prossimo decennio, un progressivo affermarsi di queste posizioni e, se non proprio l’indipendenza totale, almeno una autonomia assai ampia delle varie repubbliche, con forse la trasformazione dell’URSS in una confederazione.
La crisi del cosiddetto “socialismo reale”, la messa in discussone di certe realtà considerate dopo tanto tempo ormai acquisite, ha avuto le sue ripercussioni anche in Italia. Il PCI è giunto al punto di dibattere al suo interno l’ipotesi di un mutamento di nome e di sigla, anche se sul piano elettorale non pare ancora avere subito danni rilevanti a causa degli avvenimenti in Cina e in URSS, pur se di segno opposto, non andando al di sotto dello “zoccolo duro” del 25-26 per cento nell’ultimo sondaggio elettorale seguito al massacro della Piazza Tienammen. I socialisti sono sulla cresta dell’onda, anche per lo sfaldamento della socialdemocrazia. La democrazia cristiana cavalca vari cavalli, ma è sempre più preoccupata dei propri maneggi interni. La famosa “cosa pubblica” è allo sfascio e gli scandali sono all’ordine del giorno. E la Destra? La Destra, il MSI, non sembra saper approfittare delle occasioni vedendosi levare dalle mani un vecchio strumento come quello dell’anticomunismo preconcetto e di maniera: il partito, ormai accettato a quasi tutti i livelli, tranne sporadici sussulti di visceralità antifasciste, mostra la corda di una ideologia tutta impostata sulla difesa, non propositiva, e si vede addirittura espropriare di alcuni suoi “cavalli di battaglia” dal PSI (elezione diretta dei sindaci, lotta alla droga, ecc.).
In realtà però, almeno sino a questo momento, tanti profondi mutamenti di fatto non hanno ancora inciso sul piano ideologico di fondo, anche se le riforme gorbacioviane hanno messi in discussione l’economia statalizzata, il rifiuto dell’iniziativa privata, il dogma che “la proprietà è un furto” e così via. Anzi, l’“occidentalizzazione” dell’Unione Sovietica fa pensare al suo recepimento degli elementi più deteriori del modo di vita americano, ad una conferma della materializzazione dell’esistenza sotto un altro segno in apparenza opposto, quello dell’edonismo e del consumismo. Insomma, la famosa “tenaglia” di cui parlava Julius Evola già nel 1929 (2) non si sta allentando affatto, ma sembra voler stringere ancora di più la vecchia Europa, sul piano esistenziale e sia quello dei valori. E allora sorge spontanea la domanda: che senso può avere oggi, ad appena due lustri dalla fatidica conclusione del secondo millennio, un libro come Gli uomini e le rovine senz’altro necessario nel 1953 per la generazione dei giovani che “non avevano fatto in tempo a perdere la guerra”, senz’altro utile per i giovani del 1867 e del 1972 che “non fecero in tempo a perdere il Sessantotto”? Le sue indicazioni hanno sempre un valore, le sue precisazioni e messe a punto servono ancora? I giovani della Classe Settanta, cresciuti nel post-Sessantotto, in un’atmosfera priva addirittura delle “certezze” che hanno prodotto prima la contestazione e poi il terrorismo, vissuti durante l’apologia degli yappies, possono ancora attingere a quest’opera che definire di dottrina politica è forse limitativo?
L’Italia del 1989 è profondamente diversa dall’Italia del 1953, del 1967, del 1972 sia dal punto di vista politico che dal punto di vista sociologico: da un lato si è in genere ormai conclusa – come si è accennato – la discriminazione contro la Destra, sia sul piano politico che sul piano culturale, e anzi gli Anni Ottanta hanno messo in risalto la crisi della cultura di sinistra con il suo recupero di autori, temi e quindi testi una volta ostracizzati perché di destra; dall’altro il nostro paese vive un aumento di benessere materiale con la “crescita zero” della natalità, un costante fenomeno dell’urbanizzazione, dell’abbandono dei mestieri, e il concomitante aumentare dell’immigrazione del Terzo e Quarto Mondo con un sempre maggior numero di africani ed asiatici che prendono il posto di quelle categorie ormai inesistenti, una endemica disaffezione dei giovani per la politica e l’impegno ideologico, la rapida affermazione nell’arco di un decennio dell’informatizzazione della via sociale, il superamento di modi di comportamento collettivo in apparenza saldi a causa dell’introduzione di strumenti come il personal computer, i videoregistratori, i giochi elettronici pubblici e privati.
In questo scenario futuribile ha un qualche senso ripresentare le idee sostenute da Julius Evola per la prima volta 36 anni fa, sostanzialmente confermate 22 e 17 anni fa? La risposta è in genere sì, per il semplice motivo che le “rovine” che Evola vedeva intorno a sé nel 1953 e nel 1967 e nel 1972 ci sono ancora, non sono state affatto rimosse. Esse non erano certo concrete, ma chiaramente morali, spirituali, ideali, ed oggi, a dieci anni da Duemila, se abbiamo assistito ad una furiosa ricostruzione delle rovine materiali in Italia e nel mondo, altrettanto non si può dire delle altre. Ha un senso, naturalmente, ma purché si continuano a considerare le idee espresse da Evola come egli stesso intendeva: “Il presente libro”, egli scrive nella sua seconda edizione del 1967 a conferma di quanto aveva già detto,ne Il Cammino del Cinabro del 1963, “fu scritto non senza relazione con una determinata situazione italiana. Nel 1953, quando esso uscì in prima edizione sembrava che in Italia fossero presenti le condizioni per dare inizio alla formazione di uno schieramento di Destra: di Destra non nel senso politico, ma anche e anzitutto ideale e spirituale. Così non aveva ritenuto inutile formulare i principi, i valori e le linee principali di una dottrina dello Stato da servire per questo eventuale schieramento, non nell’idea di una loro possibile diretta assunzione e realizzazione ma essenzialmente nell’intento di indicare una direzione di marcia (…) Così esso potrà sempre valere in termini di testimonianza, di presenza e di punto di riferimento, quale pur sia la situazione attuale”.
Mentre nel corso della trattazione veniva più volte sottolineato che “problemi di politica concreta cadono fuori dal quadro del presente libro” (p. 241). Se la posizione dell’autore è dunque estremamente chiara ed inequivocabile, altrettanto deve esserlo quella di coloro che il suo saggio leggono: formulazioni di principi, valori, linee principali che servano da punti di riferimento e indichino una direzione di marcia per una Destra in senso ideale e spirituale. E questa impostazione può senza dubbio avere una sua validità e utilità anche alle soglie del Duemila, così come la ebbero per i venti-trentenni del 1953 e per i loro coetanei del 1967, per coloro che dovettero affrontare l’antifascismo viscerale del primo dopoguerra e per coloro che si trovano coinvolti in una “contestazione globale”al sistema non promossa da loro.
Oggi che la contrapposizione violenta fascismo-antifascismo non c’è quasi più, che nelle aule e nelle piazze il terrorismo e la prevaricazione politica sono praticamente scomparsi, ma le “rovine” causate dal materialismi ideologico, dall’edonismo sociale, dalla paura della droga e dell’AIDS permangono ed aumentano, è però da chiedersi se quei principi, quei valori, quei punti di riferimento possono essere ancora utili. La direzione di marcia indicata può ancora valere per trovare un percorso fra tante macerie spirituali non più rimosse e che anzi ingombrano ancora il campo e vanno sempre più accumulandosi?
Anche a questa seconda domanda, più specifica della prima, la risposta può essere affermativa, purché si sappiano rettamente intendere le parole di questo libro. Esaminandolo per linee generali rispetto alle tendenze del nostro tempo, del tempo in cui viviamo ed operano le nuove generazioni. Non c’è il minimo dubbio che alla fine del Millennio si siano sempre più accettando le tendenze alla massificazione più totale, alla planetarizzazione di mode e gusti, al livellamento delle differenze, di contro a crearsi di specializzazioni e quindi di èlites sul piano però esclusivamente materiale: a fronte di tutto ciò Gli uomini e le rovine rivendica, come scrive J.V. Borghese in una presentazione che risale anch’essa come il libro a 36 anni fa, la qualità contro la quantità, lo spirito contro la materia.
In altri termini la persona contro l’individuo atomizzato sul piano del singolo, l’organicità contro il totalitarismo sul piano della collettività. In una società che per decenni ha cercato di estirpare le radici della propria identità sia a livello storico che culturale Gli uomini e le rovine rivendica l’esigenza di un atteggiamento rivoluzionario-conservatore: “rivoluzionario come negazione decisa delle ideologie e dei miti che dominano nel mondo attuale”, e conservatore come recupero di quanto del passato può essere utile alla riaffermazione di quello che era stato, appunto, sradicato e può essere ancora valido.
“Ciò che si tratterebbe di “conservare” e difendere “rivoluzionariamente” , scrive Evola (p. 18), “è una concezione generale della vita e dello Stato che, basata su valori e interessi di carattere superiore, trascenda nettamente il piano dell’economia e quindi tutto ciò che può definirsi in termini di classi economiche”. Di conseguenza, aggiunge (p. 19) con parole che si tendono a dimenticare, è necessario “pur tenendo fermo ai principi, abbandonare eventualmente tutto ciò che deve essere abbandonato, invece di irrigidirsi o gettarsi allo sbaraglio quasi per panico e di cercare confusamente idee nuove quando si verificano delle crisi ed i tempi mutano”, perché “nel suo significato vero e vivo tradizione non è supino conformismo a ciò che è stato, o inerte, continuarsi del passato nel presente.
La tradizione è, nella sua assenza, qualcosa di metastorico e, in pari tempo, di dinamico”. Sul termine “tradizione” molto si è discusso ed anche ironizzato in un’epoca come l’attuale dove vale solo “il miraggio della civilizzazione tecnica, la fascinazione esercitata da certi innegabili progressi materiali” e in cui volge sempre “la fisima progressista secondo la quale qualsiasi cosa nuova rappresenterebbe un più e un meglio rispetto a ciò che l’ha preceduta” (p. 24). Che vuol dire seguire la Tradizione nel mondo del computer, in una società che si teorizza “multirazziale”, alla vigilia dell’apertura dei confini europei, sulle soglie del Terzo Millennio? Vuol dire, scrive Evola, che ciò avverrà grazie allo “stile di chi, ove le circostanze mutino, ove crisi si pronuncino, ove nuovi fattori prendano ad agire, ove le precedenti dighe vacillino, conserva il sangue freddo, sa abbandonare ciò che va abbandonato affinché l’essenziale non ne resti compromesso, sa portarsi avanti studiando impassibilmente forme adatte alle nuove circostanze e con esse sa imporsi, tanto che una immateriale continuità sia ristabilita o mantenuta, ogni agire, privo di base e all’avventura sia evitato” (p. 26).
E non c’è dubbio che i principi enunciati ne Gli uomini e le rovine sul piano del singolo e del collettivo sia ancora un tentativo da perseguire. Ma come, ripetiamo, in un mondo che si avvia a rendere l’uomo, più che un numero come si diceva una volta, un semplice input fatto proprio dagli elaboratori elettronici? Come ci si deve comportare in una civiltà che continua a considerare la macchina non un semplice mezzo ma il proprio fine, il proprio ideale?
Qui Evola ha parole assai chiare, e in più di una occasione, che conviene ricordare e sottolineare a causa degli equivoci in cui può cadere chi non accetti in linea di principio di diventare schiavo delle creazioni che dovrebbe dominare per rendersi più agevole la vita, e interpreta la “Tradizione” proprio nel modo sbagliato indicato da Evola: “In molti settori della vita contemporanea”, egli afferma (p. 132-3), è necessario “un fondo eroico”, “un certo livello di tensione”, quasi come se si fosse in un campo di battaglia, riferendosi invece a “tutti gli aspetti del vivere moderno che, per poter essere padroneggiati, per non avere effetti distruttivi sul singolo esigono un’assunzione completa della propria posizione, un essere in atto tale che, come nel soldato, non si rifugga dal far del rischio e della disciplina una parte integrante del proprio modo d’essere”; non solo: un simile atteggiamento vale anche in un’ottica più generale, nei confronti della “cultura in senso moderno”, la quale, prosegue Evola (p. 166), “cessa di essere un pericolo solo quando chi ne faccia uso possegga già una visione del mondo. Solo allora si sarà attivi rispetto ad essa: appunto perché allora si disporrà già di una forma interna come guida sicura quanto a ciò che può venire assimilato e ciò che invece deve essere respinto”.
Tale atteggiamento deve valere però soprattutto sul piano materiale: “Naturalmente”, sottolinea nella conclusione del libro (p. 249), sarebbe utopia pura volersi contrapporre praticamente a tutto quel che è materialmente civiltà moderna; fra l’altro, ciò comprenderebbe la rinuncia ai mezzi fattuali necessari oggi per ogni difesa e per ogni attacco. Però si possono sempre fissare una distanza e un limite. Si può circoscrivere ciò che è “moderno” in un dominio materiale e “fisico” ben controllato, nel piano dei semplici mezzi, per sovrapporgli un ordine più alto adeguatamente difeso dove i valori rivoluzionario-conservatori dovrebbero avere un incondizionato riconoscimento”.
Il che fa piazza pulita di tutti coloro i quali se la prendono con gli strumenti del mondo moderno in nome della Tradizione, dimenticando appunto che sono tali – strumenti, media – e che devono restare su questo piano per quanti hanno in sé quello che Evola in più punti, soprattutto in Cavalcare la tigre, definisce l’egemònikon, il sovrano interiore. Sicché vale la pena aggiungere un’ultima citazione, da un articolo apparso nel 1968 e pubblicato come appendice alla terza edizione del saggio. A proposito della cosiddetta “contestazione globale”, scrive (p. 257-8): “Chi se la prende soltanto con la società tecnologica organizzata dovrebbe chiedersi, del resto, se egli sinceramente sarebbe disposto a rinunciare a tutte le possibilità pratiche che essa offre per riesumare, più o meno, lo stato di natura di Rousseau. Secondo noi, ogni uomo che abbia un dominio su sé stesso può sempre fare un uso equilibrato di tali possibilità, riducendo a un minimo i corrispondenti “condizionamenti” livellatori e spiritualmente deleteri”.
Le “rovine” del mondo degli Anni Novanta sono diventate elettroniche, cibernetiche, ma continuano ad esserci: ci si deve comportare di conseguenza senza accettare di farne parte, né rifiutarlo in toto perché tra esse viviamo, far uso senza esserne usati delle sue disponibilità, la “torre” dovendo essere interiore non esteriore. Sul piano più generale l’insegnamento tutt’ora valido è quello dell’organicismo in cui ciascuno ha la propria dignità, qualunque posto occupi, dall’artigiano al capo. Con uno di quei singolari mutamenti che avvengono nel corso della vicenda umana, la Destra degli Anni Ottanta si è trovata a difendere il particolarismo, proprio e altrui, rinunciando al progetto più ampio dell’Imperium, tipico di tanta Destra giovanile degli Anni Cinquanta, pur tenendo da conto il concetto in sé.
Di fronte ai due Imperi soprannazionali usciti rafforzati dalla seconda guerra mondiale, quello americano e quello sovietico, e alle loro influenze materiali e spirituali, l’unica difesa possibile – è sembrato – consiste nel mettere avanti le proprie specificità nazionali e culturali. Da qui la difesa della “comunità” rispetto ad uno Stato totalitario e totalizzante per “democratico” che esso si autodefinisca. E la comunità non è altro che una trasposizione in formato ridotto dell’organicità evoliana.
“Stranieri in questa società decadente, è ora che gli uomini in piedi tra le rovine”, rinunciando al tentativo di ricostruire grandi sistemi statuali, prendono coscienza delle proprie fonti comuni, nell’ambiente di comunità più ristrette”, suggerisce Giuseppe Del Ninno nel 1975 presentando la terza edizione di Orientamenti (3). Mentre Marcello Veneziani introducendo dieci anni dopo la quarta edizione dello stesso opuscolo, ricorda che è necessario intendere in un modo ben preciso la nota tesi evoliana secondo cui bisogna riconoscere “la Patria nell’idea”: egli, scrive, “certamente non ha dinanzi a sé l’ideale dell’universalismo proletario, né l’apolide individualismo capitalistico, piuttosto si richiama all’ideale cavalleresco che Evola ritrova nello spirito legionario. Un ideale siffatto può in realtà essere concepito come un richiamo ulteriore e non antitetico al “senso della Patria”, un di più e non un tutt’altro; altrimenti nel nostro tempo rischia di tradursi in una spinta ulteriore allo sradicamento, in un fattore, profondamente disorganico e decisamente disgregatore rispetto ad ogni integrazione comunitaria” (4).
Gli Anni Novanta, date le premesse di cui si è detto in precedenza, sembrano dunque nascere sotto l’insegna della “nazionalità”, più che del nazionalismo. Soprattutto nell’Est europeo, sia negli Stati in cui il comunismo s’impose dopo il conflitto, nella seconda metà degli Anni Quaranta, sia in quelli inglobati a varie riprese nell’URSS, si sta assistendo ad una esplosione di rivendicazioni: la lingua, la religione, la cultura, addirittura la bandiera e la denominazione ufficiale dello Stato sono ripristinate comperano prima dell’avvento della dottrina marxista imposta da Mosca. Se viene considerata legittima questa ribellione in nome in nome di una identità originaria, per quale motivo non deve essere ritenuto legittimo in Occidente conservare la propria specificità rispetto al livellamento culturale e ideologico prodotto dall’americanismo? Soprattutto in un momento in cui, faccia breccia nella “cortina di ferro”, essa sta penetrando nei suoi aspetti più vistosi e clamorosi anche nel modo di vivere dell’Est. Forse perché esso è “democratico”, mentre il comunismo no?
La questione del ripristino o della conservazione dell’identità sociale, culturale e ideale di una nazione, sarà forse il problema più esplosivo del prossimo decennio per l’Europa: a Est per il risveglio di un orgoglio nazionale e per opporsi alla mescolanza artificiale di razze ed etnie operata da Stalin; ad Ovest per l’immigrazione dal Terzo e Quarto Mondo in atto senza alcun controllo ormai da anni. E se fino ad oggi gli intellettuali, i sociologhi e lo Stato stessi si sono preoccupati e occupati di tutelare l’identità di “minoranze” di varia estrazione, ci si chiede perché non si dovrebbe preoccupare di tutelare l’identità di quella che è ancora una maggioranza. Così, di fronte alle nuove prospettive demografiche degli Anni Novanta e del Duemila e oltre, che pur hanno le loro premesse nei periodi precedenti, certe considerazioni fatte a tale proposito ne Gli uomini e le rovine risultano abbastanza “dattate”.
Evola, come già per il concetto di “patria”, parte dal primato dell’ “idea” e dall’ipotesi di Sombart che un calo della natalità metterebbe in crisi il capitalismo. Oggi, però, con l’automazione e la robotizzazione non è più necessaria tanta manodopera come un tempo, mentre, pur decrescendo la popolazione, il fenomeno del “consumismo” subirebbe una flessione non significativa, almeno a medio termine. Di conseguenza, il decremento costante della natalità, il raggiungimento della “crescita zero”, il superamento di questa soglia, l’invecchiamento della popolazione, conducono verso il pericolo di una crisi, di una morte, di una scomparsa della cultura, della sua ibridizzazione con popoli e culture diverse, in questo caso del Terzo e Quarto Mondo.
“Uno degli aspetti centrali dell’attuale evoluzione demografica è proprio il rischio, tutt’altro che ipotetico, che a causa della loro progressiva contrazione il popolo italiano, e più in generale i popoli europei, cessino di “continuarsi”, lasciando così morire la nostra civiltà”, scrive Gianni Rossi in un saggio estremamente documentato sull’argomento (5). L’avvio di questa curva discendente si è avuto negli Anni Ottanta con un tasso di fecondità per l’Italia calato dall’1,3 dal 2,4 mantenuto sino al 1975: “Da un decennio dunque l’Italia si sta preparando un destino demografico che contempla l’estinzione non solo come possibilità teorica, ma come evento probabile nel lungo periodo. Nel breve e medio periodo la prospettiva ha un nome certo non più affascinante: invecchiamento”, commenta Rossi (6). Uno studio dell’istituto di Ricerche sulla Popolazione del CNR presenta tre possibili scenari dell’Italia del futuro elaborati nel 1985: se il tasso di fecondità resterà costante sul l’1,4 la popolazione italiana scenderà dagli attuali 57, 3 milioni a 50,4 milioni nel 2025 con gli ultrasessantenni pari al 29 per cento; se il tasso di fecondità sarà di 1,3 la popolazione scenderà a 44,5 milioni con una percentuale del 33 per cento di ultrasessantenni; se invece il tasso di fecondità a 2 figli per coppia, nel 2025 si avrebbe un modesto incremento di popolazione che giungerebbe a 59,1 milioni con un 25 per cento di ultrasessantenni (7).
Un’ulteriore analisi è stata compiuta dall’Istituto Generale di Statistica nel novembre 1989 proiettata a cinquant’anni di distanza nel 2037 se la fecondità resterà costante come è ora gli italiani saranno 46 milioni con circa 310 mila nati e 805 mila morti all’anno; se la fecondità sarà ancora decrescente la popolazione si attesterà sui 42 milioni ; se la fecondità avrà invece un ripresa si salirà ai 59 milioni di abitanti. Rispetto all’elaborazione del 1985, come si vede l’ISTAT è più pessimistico. Naturalmente, in questi calcoli è escluso il movimento migratorio e la sua natalità, entrambi difficili da prevedere e quantificare. Alla domanda: che riempirà inevitabilmente questi vuoti? la risposta appare più che scontata, data la situazione e per le sue premesse.
Non è più possibile respingere i nuovi venuti: non solo quelli europei con l’apertura delle frontiere del 1° gennaio 1993, ma ormai neppure gli africani e gli asiatici. È però possibile da un lato controllare la situazione a monte e a valle, con leggi giuste e logiche per tutti. Sempre – è ovvio che lo si voglia e non si abbia paura della demagogia spicciola di chi usa il termine “razzista” ad ogni piè sospinto. Dall’altro lato sarebbe indispensabile possedere una tale forza culturale effettiva tale da integrare gli immigrati in una più ampia visione nazionale ed europea, per non scomparire come entità autonoma in un informe crogiolo ribollente di tutto e di nulla.
Ma per ottenere questo risultato è necessario non solo avere la forza e la certezza dei propri valori, ma possedere i valori stessi. Il che per il nostro paese e del tutto problematico e rende quanto esposto un po’ una utopia. Se si riuscirà ad attuarla invece si avrà forse qualcosa di nuovo innestato su radici antiche (8). È quanto in effetti riuscirono a realizzare i veri grandi imperi del passato, l’Impero romano e il Sacro Romano Impero, ecumeni che avevano un punto di riferimento informatore ed in cui ognuno conservava le proprie particolarità, aveva il proprio posto, possedeva un fine ed un compito con riferimento all’ “alto”, riuscendo a raggiungere una integrazione conservando le specificità.
È quanto, peraltro, Evola stesso propone per il concetto di “Europa”, e che in questo caso si dovrebbe applicare in piccolo, su scala ridotta, all’interno di una nazione singola e così il concetto di “impero” cacciato dalla porta rientra dalla finestra non fosse altro che per certi concetti generali e direttivi. Se non sarà così prevarrà il caos alimentato da ogni tipo di demagogia: sia razzista, sia da un tipo lacrimevolmente umanitario e universalista, che è anche peggiore della prima. E sarà un dramma per tutti. La soluzione, ce lo dicono anche le vicende dell’immigrazione italiana all’estero, non è comunque impossibile e impensabile si veda quello che accade per le nostre comunità in grandi paesi come gli Stati Uniti: integratesi con gli anni in quella cultura, cittadini americani a tutti gli effetti, credono in quei “valori” ed hanno contribuito a diffonderli, anche se spesso restano attaccati alla madrepatria per più generazioni tanto da avere associazioni culturali per la difesa degli italo-americani, e quartieri caratterizzati dalla loro presenza e dalle loro tradizioni.
Ma ci sono voluti decenni per raggiungere questo risultato ed una società dai valori “forti” e radicati come quella statunitense. Le considerazioni che Evola fa sul tema del “negro” inteso come uno dei “tabù dei nostri tempi” nell’appendice Gli uomini e le rovine del 1972, perché come tale venne imposta dalla cultura progressista, possono quindi essere intese a mò di replica nei confronti di quel tipo di demagogia anti-bianca, e a mò di proposta di soluzioni che in parte possono essere applicate ancora oggi, come l’incentivazione a tornare nell’ambito della propria cultura di origine per non diventare degli sradicati, adattandole alla nuova e imprevedibile situazione che si sta venendo a creare con un’immigrazione incontrollata. Se è necessario tutelare le identità culturali dei popoli, allora lo si deve fare per tutti e non esclusivamente per alcuni.
In conclusione, come di fronte al livellamento ideologico e culturale accentuato dalla cultura del computer è necessario vere dei punti di riferimento interiori, così di fronte al livellamento mondiale d cui si avvertono i primi sintomi con la clamorosa crisi del “socialismo reale” è necessario che le comunità nazionali mettano in evidenza la loro tipicità per non lasciarsi annullare in una way of life universalista. È un’ipotesi più che probabile, anzi possibile: è la fine della storia. Francis Fukuyama, direttore del Servizio Pianificazione del Dipartimento di Stato americano, ha pubblicato un saggio intitolato The End of History?, in cui si sostiene che il liberalismo occidentale ha vinto la sua guerra contro il comunismo orientale: senza più nemici, senza più contrasti ideologici, tutto sarà risolto, compiuto, fermo, immobile, senza storia. Una bella prospettiva non c’è che dire, per di più prevista e annunciata proprio dai “vincitori”. Chi non la pensa come il capitalismo trionfante e come il marxismo sconfitto, cosa deve fare se non cercare di restare in piedi fra le rovine di una Storia che si è ormai bloccata senza più progredire ineluttabilmente, dove tutte le ideologie sono appiattite in una sola?
Un libro scritto 36 anni fa può dunque offrirci molti spunti su chi meditare, parecchi riferimenti da tenere presenti, indicazioni superstoriche e metastoriche da non dimenticare, anticipazioni sorprendenti su cui riflettere, al di là degli elementi contingenti e più “datati” di cui lo stesso autore aveva coscienza. Insomma, una direzione di marcia per evitare gli ostacoli costituiti dalle macerie di una civilizzazione che si avvia allegramente verso la “fine della storia”, il massimo d’entropia, l’utopia elettronica, senza più conflitti ideali, senza più alcuna differenza etnica, religiosa, nazionale, ideologica. Si chiuderebbe affine così la Grande Tenaglia, il materialismo nei due suoi aspetti americanismo e bolscevismo, prevista da Evola sin dal 1929 (9). Compete alle generazioni che alle soglie del Terzo Millennio avranno vent’anni, la decisione se confondersi tra queste rovine, oppure restare in piedi al di sopra di esse, come veniva indicato già nel 1953.
Gianfranco de Turris
Note
- Marcello Veneziani, Evola e la generazione che non ha fatto in tempo a perdere il Sessantotto, in AAVV, Testimonianze su Evola cit., p. 330-1.
- Cfr. Julius Evola, Americanismo e Bolscevismo, in Nuova Antologia n. 1371, Roma, maggio 1929. Come è noto, quegli stessi concetti vennero ripresi cinque anni dopo nel capitolo conclusivo di Rivolta contro il mondo moderno (Hoepli, Milano 1934. Il testo originario lo si può trovare ora in: Julius Evola, I saggi della “Nuova Antologia”, Edizioni di Ar, Padova 1970.
- Giuseppe Del Ninno, Introduzione a Julius Evola, Orientamenti cit., p. 11-12.
- Marcello Veneziani, Prefazione a Julius Evola, Orientamenti, Edizioni Settimo Sigillo, IV ed., Roma 1984. p. 13.
- Gianni Rossi, Una scommessa per l’Europa, Edizioni Settimo Sigillo, Roma 1987. p. 33.
- Gianni Rossi, Una scommessa per l’Europa cit., p. 35.
- Gianni Rossi, Una scommessa per l’Europa cit., p. 36-9.
- Cfr. su questa problematica, oltre al citato libro di Gianni Rossi, anche l’ampio Dossier Immigrazione, in Pagine Libere n. 15, Roma, ottobre 1988, p. 29-52.
- Cfr. Gianfranco de Turris, Neo-capitalismo, fase suprema del comunismo, in Pagine libere n. 6-7. Roma, giugno-luglio 1989.













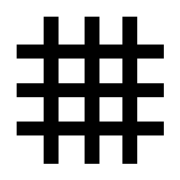





Lascia un commento